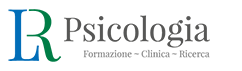NEL CADERE, RISALIRE
Una rassegna sui recenti contributi al concetto di resilienza comunitaria
di Daria Giuliani, psicologa, Esperta nella Valutazione dei Rischi Psicosociali
curato dal dott. Fabio Campetti e dott.ssa Tiziana Corsini, psicologi dell’Emergenza, Associazione Psicologi per i Popoli, sez. Abruzzo
Abstract
Il concetto di resilienza è stato oggetto negli ultimi anni di interessanti ricerche volte a tracciarne una definizione condivisa e a caratterizzarne gli aspetti maggiormente significativi.
Il presente lavoro nasce con l’intento di indagare le recenti ricerche e teorizzazioni relative al concetto di resilienza comunitaria. L’interesse per tale argomento è stato sollecitato dalla convinzione che un intervento efficace in un contesto emergenziale non può prescindere dal considerare la persona come una globalità da riattivare all’interno di una comunità. Da qui la necessità di aderire ad un approccio di intervento di tipo psicosociale che si interessi non solo alle peculiarità dell’individuo ma anche alle risorse e criticità della comunità colpita dal disastro.
Parole chiave
Resilienza individuale, Resilienza comunitaria, Evento disastroso, Fattori di protezione e di rischio, Processo adattivo, Capacità adattive.
Introduzione
Come rilevato dall’analisi condotta da Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche e L. Pfefferbaum (2008) circa lo stato attuale del termine resilienza, è possibile individuare in letteratura molteplici definizioni di resilienza, ciascuna interessata ad enfatizzare un aspetto del medesimo processo psicologico comunemente ritenuto alla base della resilienza stessa. Ciò che accumuna le diverse modalità di definizione è l’utilizzazione metaforica del termine resilienza che, in quanto parola nel suo significato originario appartenente alla fisica dei materiali, si riferisce all’attitudine di un corpo o di un sistema di ritornare alla sua forma originaria dopo aver subito una deformazione causata da un impatto. Adottato da un punto di vista psicologico, il termine resilienza si arricchisce di ulteriore complessità in quanto non meramente riferito ad un oggetto fisico, semplice e inerte ma applicato a sistemi complessi quali l’individuo, la comunità e la società.
Nella letteratura psicologica il concetto di resilienza individuale sta ad indicare la capacità dell’apparato psichico di un individuo di mantenersi compensato di fronte a situazioni avverse o a gravi esperienze traumatiche, come risultato della combinazione di forza interiore, supporto esterno e capacità di apprendere dall’esperienza vissuta (Castelletti, 2006). La resilienza è quindi la capacità di un individuo di resistere a situazioni avverse, affrontando e superando l’evento negativo e traumatico, al fine di adattare se stesso alle richieste che l’ambiente presenta in quella specifica circostanza e di imparare da tale esperienza per maturare nuove competenze e strategie, utili a fronteggiare un’eventuale situazione negativa similare a quella vissuta e superata.
Nelle ultime ricerche riguardanti il concetto di resilienza, è evidente il crescente interesse circa lo studio degli aspetti salienti della resilienza comunitaria, intesa non come potenziale caratteristica immutabile di una comunità ma come un processo messo in atto dalla comunità stessa al fine di fronteggiare un evento disastroso, volgendo ad una condizione di equilibrio come adattamento seguente un’alterazione del funzionamento della comunità.
Dalla resilienza individuale alla resilienza comunitaria
L’innovativa formulazione del concetto di resilienza comunitaria deve la sua nascita all’adesione a una differente considerazione del concetto di resilienza che, analizzato da un punto di vista ecologico, vede ampliare il significato della resilienza individuale, intesa non più, come nelle prime teorizzazioni, come insieme di tratti individuali ma come buon adattamento nonostante (a causa di) l’esposizione a fattori di rischio, a stressors o a traumi (Prati, 2006).
La situazione critica frutto di un evento disastroso coinvolge non solo i singoli individui ma l’intera comunità. Per estensione è possibile quindi pensare a un concetto di resilienza proprio delle comunità esposte a eventi avversi in quanto protagoniste dell’evento stesso e potenzialmente capaci di catalizzare le risorse interne necessarie per fronteggiare le sfide (Prati, 2006). È da evidenziare come un insieme di individui resilienti non garantisce una comunità resiliente. Ciò è dovuto al fatto che ogni individuo può esprimere in un dato momento ed in relazione ad una specifica condizione difficoltosa un determinato grado di resilienza (Norris et al., 2008). Il passaggio dalla resilienza individuale alla resilienza comunitaria non implica una sostituzione della prima ma semplicemente un focalizzare l’attenzione sulla comunità in quanto, come sottolineato da Castelletti (2006), non è la persona in sé ad essere resiliente ma è la sua evoluzione e storicizzazione in un contesto relazionale comunitario. L’individuo come membro di una comunità contribuisce con il suo grado di resilienza a render resiliente la propria comunità e di contro una comunità resiliente alimenta e stimola la resilienza degli individui che la compongono.
Ciò consente di rilevare l’aspetto altamente flessibile della resilienza comunitaria che, in quanto processo adattivo, non è caratteristica strutturante e innata di una comunità, ma indica un insieme di risorse proprie della comunità che possono essere più o meno adeguate al contesto avverso che la comunità stessa si trova a dover fronteggiare. Ogni comunità può essere vulnerabile in un dato momento e resiliente rispetto ad altre circostanze (Maguire & Hagan, 2007; Norris et al., 2008).
Resilienza comunitaria: una strategia per fronteggiare un evento disastroso
Seguendo la linea di pensiero sino ad ora delineata, risulta interessante aderire ad un recente modello elaborato da Norris e colleghi (2008) secondo il quale la resilienza, la resistenza e la vulnerabilità sono risposte differenti che una comunità può manifestare per far fronte ad una situazione di crisi, in base sia alla natura, durata e gravità degli stressors cui è esposta, sia alle risorse caratterizzanti le capacità adattive della comunità stessa.
Alla luce di ciò la resilienza comunitaria viene definita come un processo che collega una serie di capacità adattive al superamento del disfunzionamento transitorio della comunità, conseguente uno stato di crisi, al fine di raggiungere uno stato adattivo. La resilienza quindi viene attivata quando le risorse, a cui la comunità può attingere, sono sufficientemente robuste, ridondanti e di rapido accesso, quindi utili da utilizzare per riattivare un adeguato funzionamento della comunità, rendendola adatta al nuovo contesto seguente l’evento disastroso.
Tale definizione consente di distinguere il concetto di resilienza da quello di resistenza, intesa come processo messo in atto per fronteggiare una situazione di crisi, adottando risorse interne alla comunità, nel caso in cui i fattori stressogeni, pur producendo uno stato di crisi, non determinano un disfunzionamento della comunità stessa. Inoltre queste premesse consentono di evidenziare il gap tra resilienza e vulnerabilità. Quest’ultima diviene rilevante quando le risorse comunitarie non sono sufficientemente robuste, ridondanti e di facile accesso. In tale circostanza la comunità non è in grado di contrastare efficientemente lo stato di crisi. Di conseguenza lo stato di disfunzionamento transitorio è destinato a persistere.
Sapirstein (2009) ritiene che la resilienza sociale e la vulnerabilità sociale, pur influendo entrambe sulla capacità adattiva di una comunità, non siano direttamente correlate tra di loro. Infatti, col termine resilienza possiamo indicare la quantità di tempo di cui una comunità necessita per rispondere a un evento, per riorganizzarsi ed apprendere da quanto accaduto, e per ritornare a uno stato di funzionamento che garantisca un’esistenza integra e adattiva della comunità stessa (vedi anche Maguire & Hagan, 2007). Al contrario la vulnerabilità, intesa come il grado in cui la presenza di un rischio o il verificarsi di una avversità collidono con la comunità, può essere ponderata considerando i costi economici ed umani che la comunità si trova a dover sostenere. Si rileva quindi come le due variabili comunitarie siano distinte, pur se connesse tra loro. La quantità di tempo di cui una comunità necessita per completare la fase di recupero a seguito di un evento o per fronteggiare la presenza di un rischio incide non solo sulla stabilità e struttura economica di una comunità ma anche sul tessuto sociale e relazionale che mantiene coesa la società.
Come sottolineato da diversi autori (Castelletti, 2006; Pietrantoni & Prati 2006; Prati, 2006; Maguire & Hagan, 2007; Norris et al., 2009), il processo di resilienza non è mero recovery, ovvero graduale recupero di uno stato iniziale a seguito di un’alterazione, ma è la ristrutturazione di un equilibrio che vede una riorganizzazione delle parti del sistema comunitario, le cui funzioni risultano alterate a causa di un evento disastroso. Il superamento di tale stato transitorio di disfunzionamento implica un cambiamento evolutivo che nel suo prender forma non risparmia i membri della comunità dalla sofferenza e dal distress associati all’evento. Se da un lato la resilienza matura nella frustrazione, dall’altro consente di approdare in un’opportunità, in una nuova “normalità”, in un contesto sociale ristrutturato che segna un passaggio di crescita della società stessa. A tal proposito Pietrantoni e Prati (2006) parlano di crescita post-traumatica come quel processo che si verifica quando una persona (o una comunità) riesce a trasformare un trauma subito in una possibilità di arricchimento, trasformazione positiva, possibilità di crescita umana e sociale risultante dall’affrontare l’evento critico. Un recente studio da loro condotto evidenzia come i fattori maggiormente correlati con cambiamenti positivi a fronte di un evento critico sono il sostegno sociale, le emozioni positive e il coping (vedi anche Steca, 2005). Tali opportunità di miglioramento interessano principalmente la percezione di sé, la visione della vita e le relazioni interpersonali. Attualmente risulta comunque difficile stimare con esattezza la prevalenza dei cambiamenti in positivo a seguito di un evento avverso e se e quale tipo di evento può avere influenze nel determinare il miglioramento nella fase post-traumatica. Norris e colleghi (2009), pur ritenendo che la traiettoria resiliente sia un processo di adattamento funzionale, si differenziano dalle teorizzazioni precedenti, sostenendo che l’esito del processo di resilienza non sia una crescita della comunità ma una trasformazione che non necessariamente segna l’approdare ad uno stato di funzionamento migliore rispetto a quello precedente l’evento disastroso. Da questo punto di vista il processo di adattamento a una nuova realtà garantisce la partecipazione attiva dei membri della comunità al processo stesso di ricostruzione. Secondo Norris e colleghi (2009) il risultato del processo di resilienza è definibile come uno stato di benessere della popolazione, indicatore di un adattamento raggiunto con successo e caratterizzato da livelli elevati di salute mentale, modalità comportamentali e relazionali idonee, ruoli funzionali al nuovo sistema sociale ed elevata qualità della vita, ovvero valutazione soddisfacente da parte dei membri della comunità circa la propria vita in generale e i suoi specifici domini quali lavoro, scuola, famiglia, salute, tempo libero e vicinato. Nel valutare il livello di adattamento consolidatosi in una comunità a seguito di un evento disastroso è bene comunque considerare che le comunità, come gli individui che le costituiscono, possono mostrare gradi di benessere differenti sia prima sia dopo il disastro, per cui è bene porre attenzione al grado di adattamento e al suo processo di costituzione. Da queste ultime considerazioni emerge un duplice significato del termine adattamento, come processo volto a bilanciare gli effetti di circostanze critiche per la comunità e come esito di tale processo (Prati, 2006).
Resilienza come fattore di protezione
Nel definire il termine resilienza si è più volte posto l’accento su come esso si riferisca a un processo più che ad una condizione statica e consolidata di una comunità.
Questa distinzione conduce a un dibattito tuttora attivo e irrisolto relativo alla formulazione di una definizione condivisa dei fattori di rischio, di protezione e di esito nella resilienza di comunità, e ad una coerente differenzazione tra tali variabili (Prati, 2006).
In una rassegna condotta da Prati (2006) viene evidenziata, come opinione condivisa da vari autori, l’idea che se la resilienza viene intesa come processo allora i termini fattori di resilienza e fattori di protezione vengono a coincidere. La valenza protettiva della resilienza è funzionale alla comunità per difendere la sua integrità, contrastando i fattori di rischio a cui la comunità stessa può essere esposta. Per fattori di rischio si intendono circostanze avverse a cui potenzialmente la comunità potrebbe essere esposta, quali disastri, criminalità e violenza, fattori socio-culturali, fattori politici, economici e geografici. La gravità e la durata del fattore di rischio sono variabili importanti nella valutazione della resilienza comunitaria in quanto potrebbero minacciare l’azione dei fattori di protezione, minando la resilienza stessa. Confrontando i fattori di protezione, considerati in diverse ricerche riguardanti la resilienza, è possibile classificare i vari elementi di protezione a cui una comunità può attingere in fattori sociali, fattori culturali e fattori economici e politici. L’azione contrastante dei fattori di protezione sui fattori di rischio conduce a un esito del processo di adattamento, la cui buona riuscita può essere valutata considerando i così detti fattori di esito della resilienza comunitaria, ovvero gli indici economici e politici e gli indici epidemiologici.
Osservando la natura dei fattori di protezione e dei fattori di esito è facilmente comprensibile come il confine tra le due dimensioni sia molto labile e sfumato determinando una confusione concettuale, limite dello stato attuale della ricerca sulla resilienza di comunità. La concettualizzazione di resilienza comunitaria di Norris e colleghi (2008), esposta precedentemente, fornisce una soluzione possibile a tale dibattito in quanto la resilienza è intesa come processo che connette le risorse (capacità adattive) ai risultati (adattamento/benessere).
Secondo quanto argomentato da Prati (2006), per una corretta analisi dei fattori di rischio e dei fattori di protezione, è necessario considerare che la resilienza ha un ruolo fondamentale non solo a seguito di un evento critico ma anche nel periodo precedente il verificarsi di quest’ultimo, quando la comunità è impegnata nella fase di preparazione al fattore di rischio (Prati, 2006). Per resilienza si intende non solo il processo di recupero e adattamento volto a gestire le conseguenze di un impatto critico ma anche le funzioni che una comunità svolge in “tempo di pace” per prevenire e ridurre il rischio del verificarsi di circostanze critiche e promuovere le competenze della comunità stessa in un’ottica di empowerment.
Le caratteristiche di una comunità resiliente
In riferimento alla definizione di resilienza comunitaria elaborata da Norris e colleghi (2008), è di facile deduzione intendere una comunità resiliente come una comunità caratterizzata da una rete di capacità adattive, ovvero risorse con caratteristiche dinamiche, quali robustezza, ridondanza e facile reperibilità e accessibilità. Tra le quattro macroaree di capacità adattive, interconnesse tra loro nella rete di resilienza di una comunità, vi sono: lo sviluppo economico, il capitale sociale, l’informazione e comunicazione, e le competenze della comunità.
Una lettura più essenziale degli aspetti distintivi della resilienza sociale è fornita da Maguire e Hagan (2007) i quali ritengono che una comunità resiliente goda di tre caratteristiche proprie della modalità con la quale i suoi membri rispondono ad un evento critico. Secondo gli autori una comunità altamente resiliente ha la capacità di dimostrare resistenza, recupero e creatività.
Le analisi sin qui esposte sulle caratteristiche di una comunità resiliente richiedono un’ulteriore chiarimento. Nel tentativo di mostrare gli aspetti salienti della resilienza comunitaria si è parlato di capacità, proprietà, competenze. Come suggerito da Sonn e Fisher (1998), ciò non deve indurre a confondere il concetto di resilienza con quello di competenza. Una comunità resiliente è una comunità che di fronte ad un disastro è in grado di attivare un processo di adattamento utilizzando sia le risorse interne sia quelle esterne alla comunità. Con il termine comunità competente si intendono le caratteristiche di una determinata comunità, le sue capacità di coping e le risorse di cui dispone per fronteggiare l’evento avverso.
Conclusioni
Una revisione della letteratura relativa alla resilienza comunitaria consente di osservare la diversità di termini adottati per indicare le diverse componenti distintive della resilienza comunitaria. In realtà da un’attenta lettura delle varie ricerche e teorizzazioni è possibile evidenziare molti aspetti sovrapponibili. La difficoltà di elaborazione di una definizione condivisa è probabilmente resa dall’oggetto stesso di interesse: una comunità che, in quanto tale, mostra di per sé complessità a livello strutturale e nelle dinamiche ad essa interne e, inoltre, si trova a dover affrontare una situazione di crisi che infierisce temporaneamente sul suo funzionamento.
Attualmente, come suggerito dalle osservazioni di Maguire e Hagan (2007), la maggior parte delle ricerche sulla resilienza di comunità, pur se dettagliate, ci forniscono solo una conoscenza intuitiva delle caratteristiche di una comunità resiliente. Solo una minima parte fornisce un tentativo sistematico di analisi degli indicatori di resilienza. Sarebbe utile condurre analisi che non solo diano conferma della tipologia dei fattori di resilienza ma che siano anche in grado di individuare quali di questi siano maggiormente predittivi di alti livelli di resilienza. Probabilmente è possibile spiegare tale mancanza in ambito di ricerca considerando che per condurre un’analisi accurata sarebbe utile comparare le comunità che forniscono risposte differenti a disastri simili. Inoltre un recente studio condotto da Wicke e Silver (2009), pur se considerando come evento critico un omicidio, quindi incluso solo per estensione tra i disastri ed eventi avversi o estremi di cui si è trattato sino ad ora, consente comunque di rilevare quanto sia utile, per esaminare correttamente l’impatto di un evento disastro su di una comunità, combinare i risultati ottenuti da strumenti quantitativi e modalità valutative di tipo qualitativo.
Considerando che ogni comunità in un dato momento, secondo le proprie risorse e la natura e gravità dell’evento avverso può essere più o meno resiliente, è auspicabile che in un’ottica ecologica, sistemica e psicosociale da un lato si continui a fare ricerca per chiarire le attuali divergenze di pensiero circa alcuni dettagli del processo di resilienza e dall’altro si insista nello stimolare l’interesse dei governi, delle istituzioni e delle organizzazioni locali nel rinforzare la resilienza dei gruppi e delle comunità, agendo con programmi preventivi ma anche ristrutturando e rendendo efficienti i diversi settori della società.
Bibliografia
Castelletti, P. (2006). La metafora della resilienza: dalla psicologia clinica alla psicologia dell’assistenza umanitaria e della cooperazione. Testo disponibile al sito http://www.psicologinelmondo.org/pdf/Art%20Castelletti%202.pdf
Maguire, B., & Hagan, P. (2007). Disaster and communities: understanding social resilience. The Australian Journal of Emergency Management, 22 (2), 16-20.
Norris, F.H, Stevens, S.P., Pfefferbaum, B., Wyche, K.F., & Pfefferbaum, R.L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American Journal of Community Psychology, 41, 127-150.
Pietrantoni, L., & Prati, G. (2006). Oltre la tempesta. Psicologia Contemporanea, 198, 40-48.
Prati, G. (2006). La resilienza di comunità. Testo disponibile al sito di Psicologia dell’Emergenza dell’Università di Bologna http://emergenze.psice.unibo.it/pubblicazioni/ index.htm
Sapirstein, G. (2009). Social resilience: the forgotten dimension of disaster risk reduction. Testo disponibile al sito http://www.docstoc.com/docs/19830842/Social-Resilience-The-Forgotten-Dimension-of-Disaster-Risk-Reduction
Sonn, C., & Fisher, A. (1998). Sense of community: community resilient responses to oppression and change. Testo disponibile al sito http://eprints.vu.edu.au/971/1/communityresilience_(2).pdf
Steca, P. (2005). Il potenziamento delle risorse. Psicologia Contemporanea, 190, 18-25.
Wycke, T., & Silver, R.C. (2009). A community responds to collective trauma: an ecological analysis of the James Byrd murder in Jasper, Texas. American Journal of Community Psychology, 44, 233-248.
Email: giuliani.daria@gmail.com